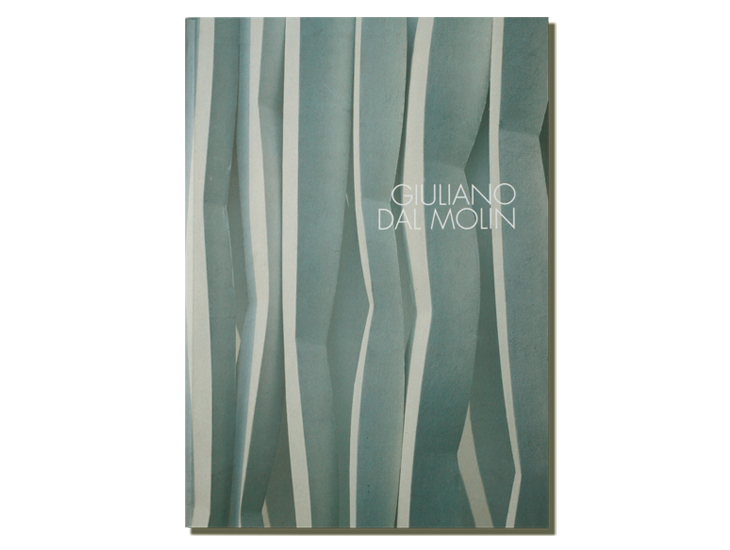
Entra ancora un po’ di brusio, di rumoriccio di vita. E’ come se le persiane di una camera lasciassero penetrare lame di luce, quando fuori è giorno ma chi vi sta dentro vuole la quiete e il silenzio del buio. Bisogna lasciar passare qualche tempo. Starsene accovacciati. Ri-prendersi. Ri-entrare. E lasciar scivolare via il caleidoscopico susseguirsi di forme, colori e suoni. Sgattaiolare dal marchè aux puches e dalle sue mille tentacolari seduzioni. E chiudere gli occhi. Senza cercare appoggi. Senza allungare le mani. E’ come prepararsi a seguire un rito. Anche se è un fatto personale, il sacro. Siamo all’ingresso di un tempio laico. Questo è forse l’unico modo per avvicinarsi. L’unico tentativo per provare ad entrare. Forse il solo consentito da chi ha ostinatamente costruito-racchiuso con una ricerca lunghissima questi luoghi. Sarebbe un tradimento non procedere in questo modo. Sarebbe violare un lavoro. Sarebbe non rispettare una volontà. Sarebbe soprattutto non capire. Stavolta non funziona la logica del fast-food con il solito interesse di scorcio, la solita sbadigliata, il solito sorriso confezionato. Stavolta, ed è quasi un’imposizione, siamo invitati a lasciare il nostro spazio ben definito, le nostre coordinate, i pregiudizi formali. Per partire alla volta di vasti territori transitori prima per poi atterrare in aree insulari, protette dalla densa ovatta che le circonda. Siamo nei luoghi di Giuliano Dal Molin. Siamo nelle sue bianche terre, dove si alzano templi monocromi. Ma dove cominciare. E’ un errore, pare, cominciare. “Gli inizi sono sempre inconoscibili, se si accerta qualcosa quello è già trafitto dallo spillo”.
Basterebbero così le avvertenze d’uso considerate sopra o se preferite le brevi istruzioni per l’avvicinamento o meglio note informative, a margine di un’opera. Basterebbero queste poche righe non servirebbero infatti che due parole, o meno, o magari nessuna ma che valessero per tutti e tutto. Un ermetico direbbe che il gran “regista è occupato, e malato imbucato chissà dove e nessuno può sostituirlo”. E’ così e non è il caso di andare oltre. La parola procede allora a tentoni, cercando di sollevare uno strato con qualche aggettivo, di sbirciare tra i concetti con qualche infinito, messo lì a mo’ di binocolo, di azzeccare la giusta combinazione. E’ quasi tutto vano. I luoghi di Dal Molin già lo rendono completamente. E senza esitazioni concettuali. Chiamo luoghi i lavori di Dal Molin. E’ una scelta dovuta. E’ L’esatta definizione delle sue opere. E’ quello che lui dice di loro. Loro, (pronome di persona) ….sono luoghi. Ma dove se ne stanno nella geografia degli spazi? Apparentemente sempre e continuamente diversi, sempre e continuamente in mutazione. Apparentemente perché non sono oggetto, non sono cose. Sono semplicemente (ancora un avverbio) forme assolute. Quando una forma è assoluta esaurisce in se tutte le relazioni. Assorbe lo spazio che le sta attorno, ricreandolo. E’ come se fosse in vuoto pneumatico. Le forme di Dal Molin auto-ritagliano con precise linee esterne, elementari nella loro primarietà. Quelle linee che la luce rende taglienti, sono però l’esatta ragione per indagare ciò che a sua volta la linea stessa cerca nella perfetta geometria interna dello spazio che stabilisce, della ragione che crea, della vita che organizza. Ed è quella linea, così innocua, così tranquilla, a diventare dunque risolutrice della ricerca che l’artista persegue in un moto di ostinata ma salvifica spiritualità che rifiuta un sistema tonale e concettuale di stretta contingenza per rivolgersi a valori “universali”.
I contorni appaiono solidi, fissi, forti, ma in realtà rivelano un’irrequietezza smisurata. Un gioco complesso di spinte e di controspinte si animano sulle superfici in incessanti battaglie strutturali su un capo aperto. E nascono così esplosioni violente, eruzioni cromatiche parossistiche. La materia polverosa si satura in spasmi, in forti contrazioni generate da una base vitrea, per poi ritornare, in movimenti sempre e comunque reversibili, alla quiete. Su questa materia, densa, vitale, organica si aprono profondità inaspettate. L’indagazione cade in pericolosi scivoli che lanciano i pensieri nelle stagioni più fredde ed inquietanti della ragione.
E qui raggiungono le terre di Dal Molin. Qui entriamo nei suoi templi che respira una dimensione temporale presocratica, dove la physis diventa l’oggetto primo dell’indagine.
Interno – esterno, fenomeno – noumeno, esposizione – risposta, sfida – reazione, richiamo ed eco, chiaro – scuro. Quelle di Dal Molin sono continue variazioni sul Tema. Non esercizi di stile. Variazioni. Fughe suonate entro valori lineari solidi ma che sviluppano prospettive concettuali arditamente modificate. Perché è proprio dalla solidità di una ricerca pura che nascono queste impensabili metamorfosi della materia e dello spazio, che diventano vere e proprie coordinate dei luoghi interni. Forme che racchiudono una mistica di idee che si riversano in altrettanti segreti, quasi tabernacoli del sacro.
Addio.
Ci siamo.
Rimane “il segreto di quegli spazi silenziosi e diversi che contengono la chiave del destino umano ma che preesistono ad ogni ricordo della sua fantasia creatrice”.
